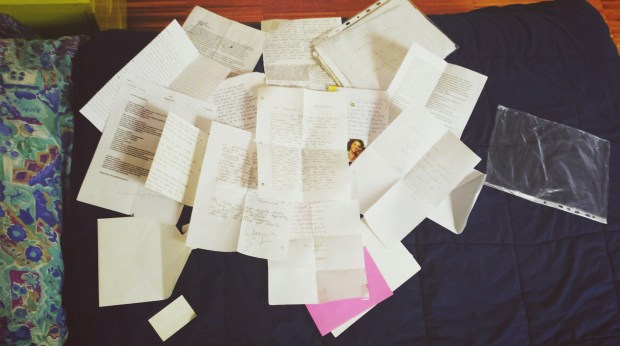Oggi piove, il cielo è grigio e io sono appoggiata all’isola della mia cucina, rivolta verso la dispensa.
Sto lavorando ma ho trovato nel ripiano più alto un sacchetto di plastica, pieno di pinoli avorio puliti e sgusciati.
La ricerca del tempo perduto non ha più la sua forza narrativa mentre mangio il primo pinolo: non è il ricordo a perdersi, né si perde il tempo passato, esso scivola via come l’acqua sotto al ponte Mirabeau di Apollinaire ma, come il poeta, je demeure.
La mia mente subito si ancora al tenerissimo ricordo della ricerca del pinolo perfetto, il gioco che amavo fare con i nonni, nella mia primissima infanzia.
Non è il tempo a perdersi, è la mente a distrarsi dal ricordo.
Ora invece tutto scorre in fila come un vecchio filmino color ocra, con una poetica e artificiale luce ramata, calda, che bagna teneramente un minuscola me e una minuta donna dai capelli neri, entrambe chine sull’asfalto del cortile di casa.
Io mi vedo alta quanto un soldo di cacio, infagottata dentro un cappotto di pelo con solo la testolina e due grasse gambotte che spuntano, fasciate dentro calze bianche.
Vedo mia nonna con il suo solito cappotto beige trapuntato e una sciarpa leggera al collo.
China com’è, la collana d’oro e corallo che ha sempre portato le pende dal collo, ma non le intralcia la ricerca che stiamo portando avanti insieme.
La mia mente di certo dilata le interminabili ore passate a cercare grosse pigne cariche di pinoli, il cui involucro mi premunivo di rompere con cura aiutata da sassi e dalle istruzioni di mia nonna, per arrivare a gustare il prelibato frutto all’interno. Ricordo che il processo iniziava sempre con qualche pinolo spappolato, perché dovevo prenderci la mano, capire come dosare la forza per aprire qualcosa di tanto delicato.
Mia nonna ne apriva per me, ma non li mangiava quasi mai: mi lasciava la gioia atavica della conquista, della caccia al cibo.
Ci vedo sempre molto buffe, con le mani sporche della polvere nera tipica del guscio dei pinoli, e non so perché ma ci vedo sole, avulse dal mondo per la nostra ricerca.
Ricordo solo lei.
Sicuramente anche mio nonno presenziava attento, ma io vedo solo noi due: concentrate, pazienti.
Sento i miei gorgoglii felici di bimba e la sua risata.
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure.